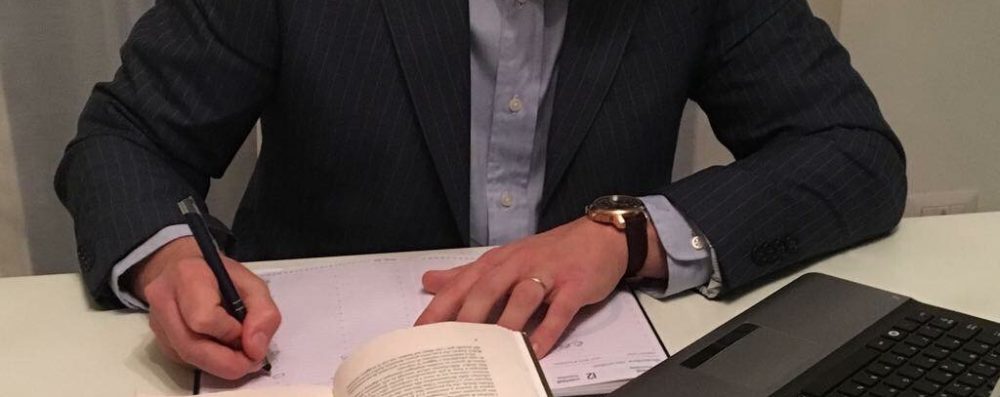La Cassazione ha confermato implicitamente questa interpretazione restrittiva. Il principio affermato dalla Corte si fonda sul consolidato orientamento del tempus regit actum: l’atto di compensazione delle perdite costituisce un momento autonomo rispetto alla loro generazione e, come tale, soggiace alla normativa vigente al momento del suo perfezionamento. Non si tratta, peraltro, di una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale tributario, dove questo principio trova frequente applicazione.
Nella pratica professionale, l’applicazione di questo principio comporta che i contribuenti debbano sempre verificare la disciplina vigente nell’anno d’imposta in cui intendono utilizzare le perdite. È opportuno precisare (aspetto talvolta trascurato) che il regime del 2011 ha comportato vantaggi e svantaggi: se da un lato ha introdotto il limite dell’80%, dall’altro ha eliminato il vincolo temporale quinquennale che caratterizzava il sistema previgente. Le implicazioni operative sono rilevanti: le società che dispongono di un “magazzino” di perdite fiscali maturate in periodi diversi devono applicare un approccio particolarmente attento nella pianificazione fiscale. Come spesso accade nella prassi, è fondamentale documentare adeguatamente l’origine e la natura delle perdite, specialmente quando si tratta di distinguere tra perdite ordinarie e quelle riconducibili a start-up.
Va considerato infine che la pronuncia in commento si inserisce in un filone interpretativo che mira a garantire certezza e stabilità nell’applicazione delle norme tributarie. È importante e fondamentale notare come la Cassazione, richiamando espressamente la circolare dell’Agenzia delle Entrate, abbia voluto rafforzare il dialogo tra giurisprudenza e prassi amministrativa, consolidando un approccio interpretativo unitario.